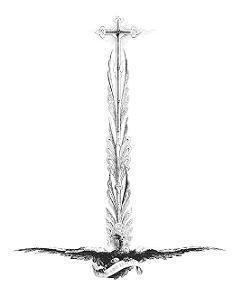
La Tecnica come Simbolo
Di Carlo Caprino
![]()
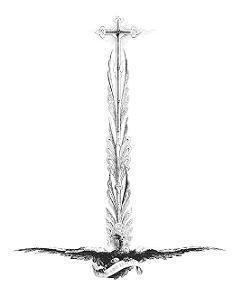
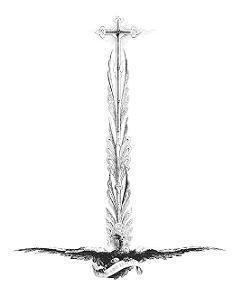 |
La Tecnica come Simbolo
Di Carlo Caprino
|
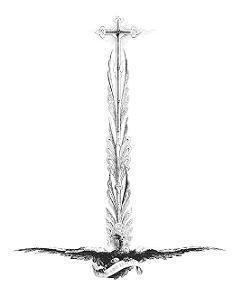 |
Premessa
La parola “Simbolo” deriva dal termine greco symbolon, con cui si
identificava un segno di riconoscimento formato dalle due metà di un oggetto
spezzato che si accostano. In una accezione più ampia del termine è un elemento
materiale, un oggetto, una figura, una
persona o una qualsiasi altra cosa che rappresenta un concetto ideale o
una entità astratta. Più sinteticamente,
nelle sue “Lettere sullo Yoga”, Sri Aurobindo afferma che:
“Un simbolo è la forma che su un dato piano, rappresenta una verità di un altro
piano...”
Così come un simbolo, in passato, permetteva di identificare colui che lo
portava, oggi tramite i simboli possiamo riconoscere verità e concetti nascosti
o dimenticati. Dico riconoscere nell'accezione etimologica del termine, non
tanto conoscere ex-novo quindi, ma “conoscere di nuovo” un qualcosa che
avevamo dimenticato, magari un archetipo di quell’”inconscio collettivo”
descritto da C.G. Jung.
Tramite il lavoro sui simboli possiamo giungere a conoscere delle verità
“incomunicabili”, non tanto perché segrete ma quanto per l'impossibilità di
essere tradotte in parole, o meglio, di essere oggetto di
comunicazione/trasmissione; è una conoscenza a cui ciascuno arriva (se arriva)
per gradi, lungo un percorso individuale, lavorando con e su sé stesso, operando
trasformazioni ad un tempo fisiche e spirituali.
Come è avvenuto in passate occasioni, un evento apparentemente casuale ha
stimolato il coagularsi di pensieri e riflessioni, apparentemente distanti e
scollegati dalla causa prima, ma in realtà (almeno per chi scrive) fortemente
collegati con rapporti di causa/effetto. Nel caso specifico, queste righe
scaturiscono dalla lettura di un breve saggio di Mircea Eliade, dedicato alle
modalità di studio del simbolismo religioso.
Nel saggio citato, l’Autore affronta nello specifico il simbolismo religioso, ma
afferma che:
“Dato che l’uomo è un ‘homo simbolicus’, e che tutte le sue attività implicano
il simbolismo, ne segue che tutti i fatti religiosi possiedono carattere
simbolico”.
Da questa affermazione possiamo ricavare che non solo tutti i fatti religiosi,
ma tutti i fatti in generale possiedono carattere simbolico, ovvero che possono
essere letti e interpretati non solo in base alla loro “apparenza” ma anche con
chiavi di lettura diverse. Ovviamente questo carattere simbolico può essere più
o meno apparente, pur essendo sempre presente, ed in alcune attività può
risaltare in maniera eclatante mentre in altre può rivelarsi solo ad un attenta
osservazione.
 In
Aikido tutto è simbolo: il gesto più semplice come l'oggetto più comune o
la parola più usata: è simbolo l'orientamento del kamiza ed il lato del
tatami dove siede il Maestro, è simbolo il nodo dell'obi , il
numero di pieghe della hakama ed il modo di piegarla, è simbolo l'inchino
ed è simbolo il kiai che ritma le varie tecniche ed il tono con cui è
pronunciato.
In
Aikido tutto è simbolo: il gesto più semplice come l'oggetto più comune o
la parola più usata: è simbolo l'orientamento del kamiza ed il lato del
tatami dove siede il Maestro, è simbolo il nodo dell'obi , il
numero di pieghe della hakama ed il modo di piegarla, è simbolo l'inchino
ed è simbolo il kiai che ritma le varie tecniche ed il tono con cui è
pronunciato.
Così quello che per qualcuno è solamente il “fine”, ovvero l'addestramento
fisico, può essere per altri un “mezzo” per eseguire un lavoro spirituale più
sottile ma altrettanto, se non più, faticoso ed impegnativo. Un “simbolo”,
appunto, per riconoscere qualcosa che abbiamo sotto gli occhi, che forse
già vogliamo ma che ancora non riusciamo a vedere, oppure che non riusciremmo a
vedere in altro modo.
Questa è la grande funzione dei simboli: superare se stessi in una continua
tensione verso una potenza che li trascende ed al cui detentore essi sempre si
volgono; dischiudere livelli di realtà altrimenti chiusi, e dischiudere livelli
della mente umana dei quali non siamo altrimenti consapevoli.
Il Mondo parla, o rivela se stesso attraverso i simboli, e tuttavia non in
linguaggio utilitaristico e oggettivo. Il simbolo non è un mero riflesso della
realtà oggettiva; rivela qualcosa di più profondo e di più fondamentale.
I Simboli [...] sono in grado di rivelare una modalità del reale o una struttura
del Mondo che non risulta evidente a livello della esperienza immediata.
[Anche in questo caso] non si tratta di conoscenza riflessiva, bensì di
intuizione immediata della ‘cifra’ del Mondo. Il Mondo parla attraverso il
simbolo [dell’Albero Cosmico], e questa parola viene compresa direttamente. Il
‘Mondo’ viene appreso come ‘vita’ e, nel pensiero primitivo, ‘la vita è un
aspetto dell’essere’.
E’ bene ribadire, a scanso di equivoci, che anche se nelle citazioni si parla di
simboli religiosi, queste note non vogliono intendere la pratica dell’Aikido
come un rito o una cerimonia religiosa (anche se non significa escludere che
questo possa essere, a determinate condizioni). Quello che si vuole sottolineare
è la “simbolicità” di una tecnica, che aldilà dell’essere un atto fisico
efficace ed efficiente, offre al praticante che abbia “occhi per vedere”
ulteriori possibilità di approfondimento.
Uno, nessuno, centomila
Questo livello “riservato” è proprio di moltissime Arti, marziali e non: così
come unico scopo dell’Aikido non è quello di picchiare prima e meglio un
avversario, unico scopo dell’Ikebana non è quello di disporre fiori in un
contenitore, così come la pratica del Cha-do non ha come unico scopo il
sorbire una tazza di té.
Certamente, arti meno “fisiche” rendono più facile allo spettatore profano
immaginare che ci siano altri scopi, oltre quelli meramente apparenti, mentre
questa intuizione è un po’ più difficile per quelle che si rifanno alla pratica
marziale.
Una prima traccia può essere ricavata da uno dei “simboli” più immaginifici e –
per certi versi – esplicativi, impiegati dall’Oriente, ovvero la scrittura
ideogrammatica e quindi, per quanto riguarda il Giappone, i kanji.
L’Aikido viene compreso nel novero delle Arti marziali che in Giappone
vengono classificate come “Budo”. Questo termine è composto da due
caratteri; il secondo, Do, indica una disciplina, un metodo, una pratica
che diventa stile di vita mentre il primo, Bu, viene solitamente tradotto
come “marziale”, “militare”, “che ha a che fare con la guerra”.
![]()
Se approfondiamo l’analisi di questo ideogramma, scopriremo che è composto da
due parti, la parte inferiore indica un piede, suggerendo l’idea di avanzare e
il principio del movimento, mentre la parte superiore rappresenta una alabarda,
quale simbolo di battaglia, combattimento o lotta. Una prima interpretazione
dell’unione dei due caratteri può quindi essere “avanzare a piedi con una
alabarda”, rendendo appieno l’azione di un fante del medioevo giapponese
impegnato su un campo di battaglia e quindi, per estensione, una azione
militare. Approfondendo l’esame però, il radicale che indica il piede può anche
esprimere l’idea di fermare, arrestare, “puntare i piedi”. Ecco quindi che
Budo può anche essere tradotto come “fermare un conflitto”, passando così da
una idea di Guerra ad una di Pace.
Una struttura essenziale del simbolismo [...] è la sua ‘polivalenza’, la sua
capacità di esprimere simultaneamente un gran numero di significati il cui nesso
logico non risulta evidente sul piano della esperienza immediata.
La porta oltre il cancello
Tecniche, attacchi o principi (apparentemente) contorti o arzigogolati, come –
sempre parlando di Aikido -
kaiten-nage, ushiro ryote dori, irimi nage e non pochi kokyu nage
possono (o, se si vuole, devono...) essere letti anche in questa prospettiva:
non solo come tecniche o principi per affrontare un avversario a mani nude o
armato di spada, lancia, bastone o coltello (e già questo chiarisce non poche
perplessità), ma come situazioni “limite” in cui affrontare sé stessi, e non
solo “l’altro da sé”.
Il simbolo religioso permette all’uomo di scoprire una certa unità del Mondo e,
allo stesso tempo, di svelare a se stesso il proprio destino in quanto parte
integrante del Mondo.
[Il simbolo ha] la capacità di esprimere situazioni paradossali, o certe
strutture della realtà ultima, altrimenti del tutto inesprimibili.
Diventa, in altre parole, un modo di provarsi, di mettersi in discussione,
utilizzando il compagno di pratica come strumento e specchio al fine di
conseguire la vittoria più importante che – come il Fondatore dell’Aikido
(e non solo lui) affermava, è la vittoria contro sé stessi.
Si potrebbe anche dire che l’addestramento è un ponte, necessario per giungere
alla nostra meta, che bisogna percorrere di buona lena senza soffermarsi più del
necessario oppure considerarlo un cancello, come affermava un Maestro di spada
giapponese.
L'apprendimento è il cancello, non la casa.
Quando lo vedi non pensare che sia la casa, devi passarci attraverso per entrare
nella casa che si trova oltre.
Poiché l'apprendimento è un cancello, quando leggi dei libri non pensare che si
tratti del Metodo.
Il fraintendimento ha fatto sì che molte persone rimanessero ignoranti sul
Metodo, per quanto esse avessero studiato e per quante parole conoscessero.
(Yagyu Munedori)
Quindi già secoli fa un Maestro di spada metteva in
guardia contro il proliferare di manuali e libri (oggi aggiungeremmo
videocassette, DVD e filmati su YouTube) e sottolineava quanto fosse
indispensabile non fermarsi all’apprendimento puro e semplice ma utilizzare
quanto imparato per fare esperienze utili alla propria crescita.
“Entrare”, “passare attraverso” sono concetti che troviamo espressi come
principi marziali sia nelle tecniche come irimi-nage o shi-ho-nage
che nelle parole di esperti come Musashi Myamoto:
Sotto la spada levata vedi l'inferno;
ma passa oltre, vai avanti;
e si apriranno le porte del paese felice.
e nei doka del Fondatore dell’Aikido, in cui Ueshiba Morihei
condensò con un linguaggio “rarefatto” ed ermetico l’aspetto pratico e
spirituale dell’Arte, rifuggendo da spiegazioni didattiche e razionali ed
affidandosi ad un “linguaggio dello spirito” che concepisce una trasmissione tra
Maestro ed allievo “da cuore a cuore”.
Impara e senti Il ritmo dell’attacco
entra e taglia: dell’Aikido i segreti giacciono in superficie.
Se tu vorrai disarmare il nemico
parti per primo entra rapido e taglia
con tutta la tua forza!
Destra e sinistra con mente fissa e ferma
ruotando schiva ogni colpo e schivata: porta l’attacco ed entra (mantenendo il
controllo)
Libero e forte evita i colpi e schiva il duro attacco del contendente tuo: entra
con forza e taglia!
Gli stessi concetti di “entrare” e “passare attraverso”, ad uno sguardo poco
meno che distratto, possiamo coglierli anche altrove, ed in maniera anche più
ampia di quanto si possa immaginare. Uno dei casi più presenti è nel simbolismo
delle Simplegadi.
Le Simplegadi (dal greco syn, insieme, e plésso, urtare, battere)
sono, nella mitologia greca, un gruppo di isole, note anche come Isole Cianee,
all'ingresso del Ponto Eusino. Si narrava che queste isole si scontrassero
continuamente fra loro (da qui il nome), costituendo così un pericolo per i
marinai che navigavano in quelle acque. Le immagini più frequenti di questa
simbologia sono il passaggio tra due rocce che continuamente cozzano insieme,
tra due montagne che si muovono senza pause, fra le fauci di un mostro
(Pinocchio, Giona, Moby Dick), il penetrare e l’uscire incolumi da una ‘vagina
dentata’, o il riuscire ad entrare in una montagna senza aperture (Alì Babà ed
il suo “apriti sesamo”).
[...] se esiste la possibilità di un ‘passaggio’, essa non può realizzarsi se
non in spirito, dando a questo termine tutti i significati che esso possiede
nelle società arcaiche, significati che cioè si riferiscono a un modo di essere
disincarnato oltre che al mondo dell’immaginario e a quello delle idee.
Sarebbe facile cedere alla tentazione di sperare che basti una parola magica o
un gesto ieratico a separare le montagne ed a spalancare i passaggi, purtroppo o
per fortuna così non è e da che mondo è mondo l’addestramento in un arte prevede
un apprendistato caratterizzato da un rigore formale più o meno accentuato, un
rigore formale che non è (o non dovrebbe essere...) fine a sé stesso ma che
serve a dare dei “paletti” che delimitano l’ambito di movimento del praticante.
Una volta che la corretta modalità d’azione è stata interiorizzata il “recinto”
non è più un qualcosa che limita ma uno stimolo a superare un ostacolo,
traguardo a cui si giunge solo e solamente quando si può e si vuole farlo.
E’ questa una delle peculiarità forse più sfuggenti del Takemusu Aikido,
una caratteristica sottile come la lama di un rasoio, che come una lama di
rasoio taglia il malaccorto che non abbia esperienza ed attenzione nel
maneggiarla.
Nell’ambito della applicazione dell’aikido nella vita reale, voglio ora portare
l’attenzione sulla parola “takemusu”. Questa viene generalmente tradotta come
“creazione spontanea di tecniche” ed è l’aspirazione di ogni artista marziale.
Questa condizione è nettamente distinta dalle tecniche che pratichiamo durante
l’addestramento, previste per l’esecuzione in un contesto ben definito e che
costituiscono un metodo per comprendere i più profondi principi della
armonizzazione, così come un praticante di body-building non esegue l’esercizio
del “curl al bicipite” per aumentare la sua abilità nell’esecuzione
dell’esercizio specifico, quanto per ottenere un aumento delle prestazioni del
muscolo interessato dall’esercizio.
Allo stesso modo dovremmo usare l’aikido nella vita reale e se ci capita di
limitarci alla mera esecuzione delle tecniche come apprese durante
l’allenamento, stiamo smarrendo uno dei fondamentali principi per essere un
artista marziale. Dovremmo usare
ogni particolare del nostro essere per realizzare la desiderata uscita dalla
spiacevole situazione in cui ci troviamo: il nostro corpo – irrobustito dalle
ukemi, il tenkan eseguito dai nostri piedi, il nostro kiai, il nostro centro
stabile, la nostra mente concentrata... tutte deve essere coinvolto ed
utilizzato.
L’epifania della tecnica
Le riflessioni sopra riportate offrono il fianco a non poche critiche, prima tra
queste la difficoltà a dare dimostrazioni logico-razionali a concetti e
riflessioni che si fondano su esperienze personali e tragitti di vita
individuali. Di fatto nulla è indispensabile nella pratica, se non la pratica
stessa; si possono eseguire per anni centinaia di tecniche senza il desiderio e
la necessità di interrogarsi su “cosa c’è dietro” e senza che l’efficacia
dell’azione e l’armonia dell’esecuzione ne vengano minimamente intaccate. Ciò
non significa che “qualcosa” – anche a nostra insaputa – non stia agendo...
La psicologia del profondo ci ha insegnato che il simbolo comunica il proprio
messaggio e adempie alla propria funzione anche quando il suo significato sfugge
alla consapevolezza.
Ovviamente essere consapevoli di determinati significati, o quantomeno avere
contezza che un significato ci sia ed interrogarsi in proposito faciliterà la
ricerca di una risposta, piuttosto che attendere che questa appaia come
d’incanto, ed essere consapevoli che un significato c’è permette di vedere con
“occhi nuovi” anche quello che ci circonda, aiuta a cogliere gli infiniti e
minuti collegamenti che uniscono tra loro ogni momento della nostra vita,
consente di immaginare cosa poteva voler suggerire Ermete Trismegisto nella
“Tavola di Smeraldo”.
Il simbolo [...] non soltanto svela una struttura della realtà o una dimensione
dell’esistenza, ma con quell’atto stesso porta un ‘significato’ nell’esistenza
umana, Questo è il motivo per cui anche i simboli che mirano alla realtà ultima
costituiscono contemporaneamente rivelazioni esistenziali per l’uomo che decifra
il loro messaggio.
[...]
Il simbolo religioso traduce una situazione umana in termini cosmologici e
viceversa; più precisamente, rivela la continuità fra le strutture
dell’esistenza umana e le strutture cosmiche.
[...]
Di conseguenza, grazie al simbolo, l’esperienza individuale viene ‘ridestata’ e
tramutata in atto spirituale. Vivere un simbolo e decifrare correttamente il suo
messaggio implica aprirsi allo Spirito e, infine, accedere all’universale.
Qualunque Arte allora, qualunque atto quotidiano, assume una valenza nuova ed
una potenza che va ben aldilà del gesto muscolare puro e semplice, e le parole
di O’Sensei Ueshiba Morihei
suonano più come una promessa che come un illusione.
Ken ga ten wo sasu uchu kara ki ga ken no naka ni hairimasu ato de hikari de
terasu
Conclusioni
Come è ovvio queste note non possono e non vogliono esaurire un argomento che –
già di per sé complesso e articolato – può trovare idonea metabolizzazione
individuale solo attraverso una pratica fisica unita ad una sincera e costante
riflessione personale. Il volerle condividere è un modesto dono ai compagni di
pratica ed un ringraziamento ai Maestri passati e presenti che ci permettono di
godere dei loro insegnamenti.
Articolo pubblicato nella rivista
LexAurea36,
si prega di contattare la
redazione
per ogni utilizzo.
www.fuocosacro.com